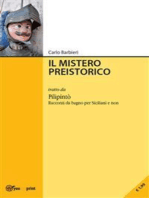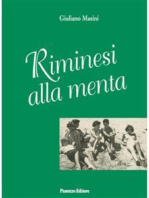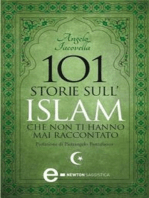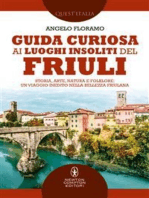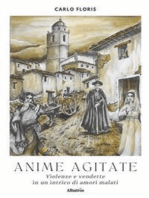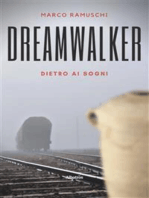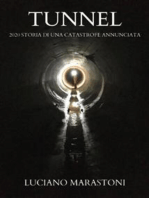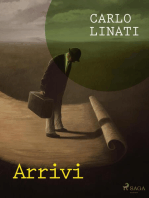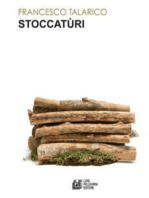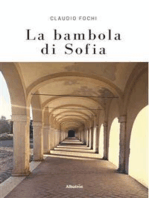Professional Documents
Culture Documents
Etiopia - Una Stagione All'Inferno
Uploaded by
Renzo Pin0 ratings0% found this document useful (0 votes)
292 views5 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
292 views5 pagesEtiopia - Una Stagione All'Inferno
Uploaded by
Renzo PinCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 5
E T I O P I A
UNA STAGIONE ALL’INFERNO
Lanciandosi un sorriso ogni tanto, le ragazze del tavolino accanto conversano fitto d’un misterioso
argomento. La più bella indossa un corpetto pastello elasticizzato ai fianchi che allunga ancor più le sue curve
appena accennate, da sirena. Fuori della vetrata del bar, un grande albero ripara un sottobosco di tavolini, coca-
cole e avventori molto compresi nel relax pomeridiano. Intanto il nostro supersucco è arrivato. Abbiamo preso a
chiamare così i bicchierozzi di denso, delizioso frappè di mango, papaya o avocado di cui è divenuta nostra
missione effettuare il controllo qualità in ogni bar d’Etiopia. Per appena otto birr, meno di cinquanta centesimi di
euro, abbiamo deciso di non privarci di nulla. Non di questo momento di requie dalla polvere e dall’ossido di
carbonio degli obsoleti minibus bianchi e blu dove i passeggeri siedono compatti. O dai mendicanti, sfrattati dalla
clinica ortopedica per casi disperati, che si spostano sui marciapiedi come ragni, alternandosi a quelli dalle vuote
orbite bianche, forse schiavi accecati dopo una storica sconfitta il cui ricordo sta svanendo assieme ai caratteri
metallici rubati ai monumenti. O, ancora, dai morti viventi avvolti in sudici sudari che ingrombrano i marciapiedi.
Chissà, forse da quei bozzoli informi uscirà un giorno una bellissima anima, ma la trasfigurazione dei reietti di
Addis Ababa sembra remotissima. Chi è cambiato sono io: adesso, finalmente, so quanto pesano gli occhi dei
diseredati sulla mia persona, quello sguardo che s’era finora fermato alle pagine dei giornali. Scappavo chiudendo
la porta dell’auto mentre fuori i bambini battevano e tendevano la mano, come da noi si fa solo con le celebrità.
Non sapevo d’essere un privilegiato per saper leggere e scrivere e per poter comunicare col vasto mondo – anche
se non in amarico.
I saggi divulgativi sulla pasticceria, sulle basi della letteratura e sull’uso del pc del sedicente Mega
Bookstore accanto (appena uno stanzone, in verità) suscitano tenerezza. Per la vendita occorrono quattro persone:
alla prima consegno i libri per lo scarico dall’inventario, la seconda incassa l’ammontare, la terza infila i libri in
un sacchetto e, all’uscita, l’ultima controlla lo scontrino. C’è anche un volumetto, sovvenzionato da una
fantomatica setta, che lancia fulmini e saette contro Sodoma annunciando il castigo a venire in assenza di una
pronta conversione. E, forse, ne ha di che: lo studente di biologia col quale avevo attaccato bottone aspettando che
la sauna pubblica, frequentatissima da ambedue i sessi, decidesse quel giorno se aprire o no (non c’era acqua
fredda, sosteneva la cassiera), ha sentito la necessità, di punto in bianco, di rivelarmi di essere omosessuale.
Buono a sapere che la pluralità della natura non sia un effetto della perdita di orientamento della civiltà
occidentale ma si presenti anche nei più diretti discendenti dei nostri antenati che, muovendo proprio da queste
terre, hanno conquistato tutto il pianeta. Gli etiopi ora sono determinati a conquistarsi il diritto di vivere – che in
molti casi vuol dire sopravvivere. Come negli anni cinquanta ci si illuminavano gli occhi a dollaro in presenza di
un americano, così per loro lo straniero, il “farangi” – richiamo costante al quale controbatto con “hàbescia”,
“autoctono”, zittendone alcuni – è uno scrigno di birr che attende solo di essere forzato. E con quale tenacia ci
provano! E quale soave pace è la pausa del supersucco, lontani dalle pressanti richieste di elemosina, di accettare
una sedicente guida o una corsa in taxi. Ma certo non posso imbrattarmi la faccia di lucido da scarpe per sfuggire
all’assalto al farangi, tanto più che spesso, senza una guida – anche una ragazzina che abbia capito cosa si voglia
visitare può bastare – è impossibile localizzare chiese, tombe e musei, tanto fitto è l’intreccio delle stradine di
Harar, tanto rare sono le indicazioni lungo le strade di Addis Ababa, tanto sprovveduto è reso il farangi da
quell’alfabeto così decorativo da meritare di figurare su magliette e poster ma che rimane, ahimé, indecifrabile.
Stamane però il percorso era chiarissimo: bandierine colorate decoravano la cancellata della chiesa di
Kiddist Maryam per la grande festa del ventuno del mese, di ogni mese, eccetto quello che di giorni ne ha solo
una manciata. Per noi era il ventinove, e chissà quale altra data per gli arabi. Un interessante calendario dava tutte
e tre le indicazioni, confermando che tutto è relativo – ora compresa: gli orologi etiopi indicano le sei di mattina
quando i nostri segnano mezzogiorno. Il giorno, logicamente e secondo un’usanza che fu degli ebrei, inizia con
l’ora zero all’alba, che a questa latitudine è assai regolare. Alle quattro, 10am ora occidentale, la ressa per entrare
nel cortile della chiesa per i rituali tre giri attorno all’edificio aveva assunto connotati da tragedia sportiva. Le
campane suonavano, il prete aveva già iniziato a blaterare attraverso un impianto di amplificazione da gruppo
punk e non avrebbe smesso per un altro paio d’ore – il tempo della visita al vicino Museo Nazionale, dove
l’antediluviana Lucy scimmiotta Shakespeare: “Molto rumore per nulla”. Difatti è alta giusto tre piedi e mezzo e
nella vetrinetta non c’è che una copia – i resti dell’ominide più antico mai ritrovato sono nei sotterranei del museo,
oggetto di studi. Più interessanti, al primo piano, alcuni scranni e chaises longues dalla concezione semplice ma
scolpite con mano sicura. Uno di noi avrà la pazza idea di acquistarne un esemplare presso un negozietto – un
affare a meri 160 birr – al quale, con nostra assoluta sorpresa, l’impiegato del check-in attaccherà l’etichetta
“Transfer Cairo-Fiumicino” senza batter ciglio. Requisito invece un geode in quanto “bene culturale dell’Etiopia”.
Peccato, aveva la forma di un uovo à la coque e togliendo la calottina si scorgevano i cristalli color ametista
all’interno. Aeroporto che vai, impiegato che trovi.
Dall’oblò dell’aereo i rilievi dell’altopiano etiope sembrano appena creati. Questa terra brulla, arcaica, ha
ispirato i primi cristiani ad un’esistenza altrettanto grezza e povera. Forse le maggiori attrazioni dell’Etiopia, i
monasteri e le chiese, sono state costruite o scavate nella roccia durante un medioevo la cui storia è perduta nel
groviglio delle contraddittorie tradizioni. La meraviglia è assoluta alla prima visita dei centri religiosi del Lago
Tana: dentro una struttura cilindrica a tucul, un sancta sanctorum quadrato – una porta su ogni facciata – presenta
scene delle sacre scritture e della tradizione etiope. Nelle varie chiese i miti e l’iconografia rimangono i medesimi:
un pescione piantagrane finalmente arpionato, un santo a cavallo d’un gallo, angeli crociati pronti a dar battaglia
ed ex-cannibali che si tagliano la lingua in segno di pentimento. Cambia solo la mano dell’artista. L’intento è
ingenuamente didascalico e lo stile fumettistico: un credo fiabesco, accessibile ai pastori e ai contadini che si
riuniscono per le lunghe celebrazioni dei giorni di festa, marcate dai tamburi, dai sistri, dai canti, dalle danze,
dalle processioni e dai ricorrenti, lancinanti ululati delle donne. Il male, nella chiesa ortodossa, è rappresentabile e
la perenne lotta col bene è un’epopea avvincente e piena di colore: al Museo Etnografico, l’unico del paese a
livello internazionale, una tavoletta illustra le fantasiose torture e morti di San Giorgio, numerose perché il santo
continuava a resuscitare. Giorgio è tra i più venerati, e ci tiene ad esserlo. Difatti, dimenticato dagli scalpellini che
avevano ricavato dalla roccia di Lalibela due intricati gruppi di chiesette, cappelle e piccoli antri per gli eremiti, il
santo apparve al re Lalibela per protestare. Per lui, il sovrano fece scavare la più perfetta delle chiese, in forma di
croce e splendidamente isolata, in un affioramento roccioso poco distante.
Interrati i luoghi sacri in labirintiche trincee o relegati fuori dalle vicende umane in isole sperdute o lungo le
coste di un lago immenso, la vocazione eremitica dei primi ortodossi – convertiti nel quarto secolo da un gruppo
di nove apostoli provenienti dal Medio Oriente – non era ancora paga: non solo lontano dal mondo, ma più vicine
al cielo dovevano essere le loro oasi di preghiera e penitenza. Tanto accanimento contro il corpo è per noi
incomprensibile, ma c’è chi sostiene che, in un quadro d’evoluzione, nessuna èra sia uguale all’altra, e che i
richiami della carne fossero più imperiosi in quei tempi e quindi, per le anime elette, più importante mortificarli.
Le cime dei dirupi del Tigray rispondevano alla bisogna, e ci hanno offerto un paio di memorabili ascese. Per
visitare la chiesa del monastero e il villaggio semiabbandonato di Debre Damo, sulla cima piatta di una tozza
montagna, occorre attaccarsi ad una fune e tirarsi su per una trentina di metri. Il pompiere del gruppo ce l’ha fatta
da solo; gli altri, dopo aver assicurato un cappio di pelle di capra due volte attorno al corpo, hanno accettato
l’aiuto di un prete che, dall’alto, tirava. Come al Monte Athos, niente donne lassù: potrebbero fuorviare i pensieri
dei pii abitanti dell’eremo. La chiesa non è particolarmente notabile, ma la situazione è unica. Negli affioramenti
rocciosi tra le case in pietra ormai disabitate, ma ancora protette da cinte di mura a secco, sono stati scavati diversi
bacini per il battesimo ad immersione, cui danno accesso alcuni scalini. Dentro, il pelo dell’acqua è
completamente ostruito dal verde di piccole piante acquatiche. A Lalibela una di queste vasche è dedicata alle
cura delle donne sterili, sebbene non osi pensare cosa possano dar alla luce dopo un bagno in quelle acque
stagnanti. Altra scalata indimenticabile è quella ad Abuna Yemata Guh. Sappiamo di esploratori che, vista la
situazione, ci hanno rinunciato. In realtà basta accettare l’aiuto (interessato) dei ragazzi della zona che conoscono
la sequenza delle mosse da fare. La parete è verticale, e piccoli incavi sono stati scavati in secoli d’uso, alcuni per
i piedi, altri, con un po’ d’appiglio, per le mani. A volte, con un’oscillazione, occorre cambiare il piede
d’appoggio – insomma, occorre sapere quel che si sta facendo, e non c’è alcuna misura di sicurezza, ma basta
essere in decenti condizioni fisiche, non guardarsi attorno e puntare con determinazione verso l’alto. In cima agli
enormi massi che paiono riparare la valle dal vento, si apre una caverna, alcune ossa umane conservate in un
anfratto, compagne delle proficue ore che vi si possono passare immersi in meditazione. Poco più su, un
cornicione largo tre palmi – parete verticale a destra e strapiombo verticale di duecento metri a sinistra – porta a
una grotta naturale, ampliata e rozzamente scolpita per adibirla al culto. In ogni chiesa, l’anticamera è tappezzata
da luride stuoie o da polverosi tappeti, e un altro vano, quello adiacente al sancta sanctorum, è accessibile, dietro
al quale però ai fedeli è vietato spingersi. Quello è il regno incontrastato del prete, che occorre localizzare ogni
volta in quanto custode delle chiavi. Il prete funge anche da bigliettaio, e rilascia una ricevuta per il pagamento del
prezzo d’ingresso, fissato di solito in 50 birr a testa, fatta eccezione per Abreha we Atsbeha, dove un foglio affisso
alla porta del cortile avvisa che il consiglio di gestione ha deliberato all’unanimità, naturalmente col solo scopo di
assicurare al turista un migliore servizio in qualunque momento della giornata, di richiedergli il pagamento di 100
birr. A questi si aggiunge, al solito, la mancia per chi sia andato a chiamare il prete, la mancia per l’occasionale
guida o sacrestano che aspetta che si abbia terminato per richiudere la chiesa, e infine la mancia per il prete stesso:
pare infatti che l’incasso del biglietto – compilato a mano in doppia copia con carta carbone – vada alla Chiesa
Ortodossa d’Etiopia. I preti, poveretti, sono a volte poco più di cenciosi relitti umani: abbiamo trovato il vecchio
“abba” di Debre Maryam, a Bahar Dar, nell’orticello, forse a cogliere l’insalata per la cena, e quello di Mikael
Barka, non lontano da Atsbi, seduto per terra con la canuta moglie, intento a togliere i sassolini dai chicchi di riso
o grano su una stuoia stesa a terra, nel cortile. Per alcuni, come quello di Debre Tsion Abuna Abraham, abbiamo
dovuto aspettare il termine della celebrazione del Timkat, l’Epifania etiope. Con quanto gusto i valligiani cantano
e ballano in processione, quanto queste feste devono star loro a cuore, proprio come ai nostri papà portava allegria
la sagra del paese con la giostra e gli autoscontri. Il prete, un aitante cinquantenne, con quattro salti si è portato
dalla vallata, dalla quale ci arrivavano in lontananza le litanie e il ritmo dei tamburi, all’altezza della strada dalla
quale osservavamo la parata di ombrelli di velluto da cerimonia multicolori. Sembrava la scena di un film
sull’Antico Testamento. Iniziata la salita, lunga e faticosa sotto il sole di mezzogiorno, ma priva di passaggi
tecnici, dopo poco lo abbiamo visto il doppio più avanti di noi, quasi le pietre sconnesse e i salti del percorso gli
scivolassero sotto i piedi. Né all’andata né al ritorno è stato possibile liberarci di un nugolo di ragazzini, del loro
incessante “iù, iù” “uèr ar iù go?” e “uozziornéim?”. La chiesa, ricavata scavando una parete color ruggine, è
circondata da un alto passaggio a ferro di cavallo che porta a una bassa stanza dal soffitto coperto di grezzi
bassorilievi, luogo di preghiera del fondatore: una vera e propria tana. Nel perfetto silenzio, il frastuono delle ali
dei colombi fa trasalire il visitatore, e la luce che entra da un’apertura, il raccoglimento e il distacco dalla materia,
i minuti stessi che si trascorrono lassù non appartengono né al nostro secolo né al tempo, ma all’anticamera
dell’assoluto. I preti, quando possono e vogliono, ci mostrano i loro tesori: volumi di pergamena più o meno
antichi dei quali offrono al mirino delle nostre compatte le pagine istoriate – di solito l’inizio di ogni Vangelo – e
le croci. Tre sono gli stili per una croce: Gondar, Axum e Lalibela. Talvolta s’incontra anche un prete spiritoso,
che per pochi birr è felice di posare col suo pastorale ornato dalla croce. Di croci sono pieni i negozi di souvenir,
come anche di altarini lignei dipinti a mano, di sculture africaneggianti – animali, maschere –, di dipinti su pelle di
vacca o pecora, di tessuti e di oreficeria in argento e oro. Ovunque si vada, i medesimi oggetti affollano stanzini e
bugigattoli che assumono l’aspetto di antri dove muoversi è un’impresa. In stanze a parte, ai conoscitori vengono
presentati i pezzi veramente preziosi – le monete antiche autentiche, i dipinti meno dozzinali e i gioielli di buona
fattura.
Ecco Gondar, il più italiano dei centri del circuito classico. Passiamo in rassegna le costruzioni coloniali: il
palazzo delle Poste, che domina la piazza centrale, il quartier generale della polizia e alcuni complessi abitativi
abbandonati. Per ripugnante che possa essere l’ideologia dietro lo stile architettonico e artistico degli anni ’30, non
si può negargli una inconfondibilità e una pulizia di linee fuori dal comune. Ci s’aspetterebbe un qualche
sentimento di rivalsa, dopo i trascorsi storici tra Italia ed Etiopia, ma no: ci dicono che l’Italia è un buon paese,
che le relazioni ora sono amichevoli. Il novantatreenne sacerdote di Wukro Chirkos ci confida i suoi ricordi in un
sorprendente italiano, ed altri ancora conoscono un po’ la nostra lingua per ragioni di affari. Non che si siano
italianizzati: poco oltre la piazza, la sera, dopo cena, dal Balageru Bar trabocca un incessante ritmo tribale.
Dentro, un trovatore, accompagnandosi con un liuto ad una sola corda, improvvisa, proprio come facevano i negri
trapiantati nelle Americhe con il blues. Una ballerina lo accompagna imitando il suono acuto del sistro: “Tssss!
Tssss!”, muovendo le spalle e scuotendo il piccolo petto. Prendono in giro gli stranieri che si sono seduti assieme
ai locali, che bevono da bottigliette monodose un vino molto ordinario o analcolici colle bollicine. Anche alcuni
ristoranti celebrano il colore locale: particolarmente gradevoli quello del Seven Olives Hotel di Lalibela,
l’”Hàbesha Kitfo” di Gondar e, a Macallè, l’”Hàbesha Village”. Per trovare quella rara specialità tutta etiope, il
“fish goulash”, sorprendentemente presente in tutti i menù ma mai disponibile, ci siamo dovuti spingere fino al
nuovo “Fresh Taste” di Harar, dove abbiamo anche potuto visitare la linea di produzione della Harar Beer
Factory, una distilleria inaugurata nel 1984 in collaborazione con maestranze cecoslovacche. In collaborazione
con missionari portoghesi era invece stato fatto costruire il castello di Guzara (1571) e i bagni di Fasilidas vicino a
Gondar, e in Gondar stessa il recinto reale, un complesso di castelli, biblioteche, depositi e stalle. Poco fuori città,
la piccola chiesa di Debre Birhan Selassie custodisce l’opera d’arte più nota d’Etiopia: il soffitto dipinto con
decine di volti d’angelo. Con la sua aria vagamente gotica, è la chiesa che più si avvicina alla nostra idea di luogo
sacro, anche se l’incessante afflusso di turisti le ha tolto l’aura religiosa. E’ così riccamente decorata perché
doveva conservare l’arca dell’alleanza, della quale si sono perse le tracce o che forse sta ad Axum, in una cappella
vicino alla Cattedrale di Tsion Maryam – non lontano da dove la stele che si ergeva a piazza di Porta Capena a
Roma, affumicata per decenni dal traffico diretto all’EUR, ora fa bella mostra di sé nel Parco delle Steli.
Tra Gondar e Axum, la meraviglia naturale dell’Etiopia settentrionale merita almeno un giornata: il parco
dei monti Simien offre paesaggi stupendi che non hanno nulla da invidiare al Grand Canyon. Sì, delle cascate del
Nilo Azzurro vicino a Bahar Dar i primi esploratori avevano pure riportato racconti eccitatissimi, ma ora che la
maggior parte dell’acqua è convogliata verso una centrale idroelettrica, sono rimaste ben poca cosa. I Simien
invece sono talmente belli che gli escursionisti organizzano spedizioni a piedi di anche più d’una settimana, con
guida, guardia (ambedue obbligatorie, a sentire il ranger che rilascia i passi) e muli per il trasporto, alloggiando
presso gli abitanti dei villaggi che costellano le pendici, coltivate a terrazze ove possibile, di questi rilievi. La
presenza di abitanti dà al parco una dimensione meno selvaggia, più abbordabile, senza però sminuire la sua
straordinaria monumentalità. Colonie di babbuini gelada scavano radici commestibili, rapaci punteggiano
l’azzurro e vediamo perfino un branco di rare capre walia ibex, una specie endemica degli alti Simien. E’ sabato
mattina presto e a Debark, il villaggio base per i Simien, c’è grande agitazione per il mercato settimanale. Un
giovanotto nudo, mantello in spalla e bastone in mano come l’Edipo del famoso quadro di Ingres, guarda il viavai,
le sue gioie in bella mostra, tra l’indifferenza generale. Forse qui è normale, chissà. Puntiamo verso nord: il nostro
autista ignora ogni regola di creanza per non rimanere dietro ad altre vetture, dentro alla scia polverosa che,
nell’aria secca, si amplifica e persiste come il fumo di un razzo. La strada che da Debark porta a Axum è lunga,
tutta tornanti, a volte anche pericolosa ma sicuramente la più panoramica d’Africa. E’ un gioiello di ingegneria
italiana che scende di circa 2.000 metri fino al fiume Tacazzè in relativamente pochi chilometri. Ora sono i cinesi
che costruiscono le strade in Etiopia – i villaggi degli operai sono protetti da un recinto di filo spinato – ma non si
cimentano in progetti così ardui. Difficile è anche un’altra strada, quella che da Korem porta a Lalibela attraverso
aspre montagne. Ogni pomeriggio si aggruma una perturbazione che verso sera scende a Lalibela. Pioggia in
Etiopia! Il nostro autista, dopo aver arrancato a lungo con coraggiosa determinazione, decide di arrendersi in
corrispondenza di alcune capanne: la visibilità è zero, siamo dentro ad una nuvola. Già immaginavo di pernottare
scaldato dalle capre – non sarebbe stata la prima volta, ma non me l’aspettavo – ma riusciamo ad arrivare a
Lalibela col calar della notte. Anche qui, come dappertutto, l’esercito delle dodici scimmie è più veloce di noi: gli
inservienti (mai parola fu più appropriata!) dell’albergo si precipitano sui nostri bagagli per portarli alle nostre
stanze senza neanche sapere quali siano. Io mi sono premunito e ho sempre il portafoglio pieno di biglietti da 1
birr…
“Chirrr-up! Chirrr-up!” I pulsanti delle fotocamere del gruppo di bianchi che, ai margini della piazza del
mercato, fissano le picchiate radenti, veloci e un tantino macabre di una ventina di falchi neri, sparano a raffica.
Sopra gli archi arabi dei depositi costruiti dagli italiani si intravede il tetto di legno, in stile alpino, della casa di
Rimbaud. Non è l’originale, ma vi si respira un’aria antica. V’è stata girata la sua biografia, “Una stagione
all’inferno”, titolo che si materializza con l’incontrovertibilità della realtà qui, tra stretti passaggi ciechi, la
spazzatura onnipresente e l’incessante assedio dei bambini di Harar. Nei cassetti degli alberghi si trovano
preservativi, timido tentativo di arginare questa piaga. Le foto centenarie al primo piano mostrano la città, la
quarta in ordine di santità per l’Islam, come avamposto di frontiera, bello e impossibile. Nulla è cambiato
nell’organizzazione quasi tribale della popolazione e nelle sue credenze: Harar vanta la più alta concentrazione di
moschee del mondo, e in sacre stanze disseminate lungo i vicoli, nascoste agli occhi degli infedeli, pesanti volute
d’incenso stagnano sui mausolei di santi uomini, a cui fanno devota e gelosa guardia vecchi in pose da odalisca.
L’impronta araba è evidente anche nella concezione della casa tradizionale. La porta s’apre su un vasto ambiente
movimentato da tre livelli, occupati a seconda del rango e dell’età. I bei tappeti esigono che le scarpe vengano
lasciate all’uscio, e i coloratissimi oggetti d’ogni giorno, quando non in uso, decorano i muri. Impressiona la
logica, la gerarchia e l’economia d’uso di questi spazi. Nella città vecchia, ancora cinta dalle mura costruite dal
sultano nel 1560, una via è dominio dei sarti, che lavorano tranquilli alle loro vecchie Singer su uno sfondo di
stoffe dai colori sgargianti. Il forte odore del caffè assale all’angolo di qualche strada, dove i chicchi dell’ottima
qualità locale vengono torrefatti o la bevanda servita, a volte seguendo il rispettoso rituale etiope. Anche il pasto
serale delle iene segue una precisa etichetta: fuori dalle mura, in luoghi designati, l’uomo delle iene chiama gli
animali per nome e, per appena 50 birr, si può assistere all’inconsueto incontro dell’umano col selvatico. Ma è la
coesione del tessuto urbano, in pianta quasi uno dei fitti disegni di Keith Haring, la vera bellezza di Harar, non
certo gli “splendidi mosaici della Asmaddin Beri”, come scrive la Lonely Planet a proposito di una delle porte
occidentali della città, che a un’osservazione più attenta si rivelano essere sudicie mattonelle dal disegno
pacchiano. Alle rivendite – mere finestre su uno stanzino alle cui pareti figurano dappertutto gli stessi prodotti –
una stecca di sigarette locali costa 50 birr, due euro e mezzo. Chi si accontenta, gode. Delle tanto sospirate Camel
Light, per ignoranza non acquistate al duty free del Cairo, in Etiopia non c’è traccia.
E non è l’unico zoccolo duro d’un viaggio in Etiopia: l’adattamento al quale si è costretti riguarda l’abc
stesso della vita. Abbiamo sentito le streghe di un gruppo che soggiornava contemporaneamente a noi all’albergo
Atse Yohannis di Macallè protestare chiedendo uno sconto perché non c’era acqua nei bagni. Oltre alle beffe
(pretendere acqua in un paese arido?), anche il danno (aspettarsi una riduzione del prezzo)? Dove credevano di
essere? Al 155° posto nella classifica dell’indice di sviluppo umano
(http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_sviluppo_umano) e tra il 70° e l’80° posto in base al Prodotto Interno
Lordo (anche se il PIL andrebbe rapportato alla popolazione per avere un’idea più precisa di quanto siano poveri)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_stati_per_PIL_(PPA), all’Etiopia non si può chiedere quel che non ha. La
ragazza bianca che, all’aeroporto, sosteneva per le manine la bambina moretta, insegnandole a camminare, quella
sì aveva capito cos’è l’Etiopia. Abbiamo visto un paio di questi piccoli viaggiare con i genitori adottivi, ed è
venuta anche a noi la tentazione di portarne via qualcuno. Il fascino dei bianchi è tale che i piccolissimi offrono la
mano per camminare assieme, quasi ad avere un contatto magico con un extraterrestre. Quelle volte, non c’è
differenza culturale che tenga: il codice della vita è uguale per tutti. Dobbiamo confessare però di esserci presi una
breve vacanza dalle privazioni degli alberghi etiopi: ci siamo concessi una notte alla Geralta Lodge, un’oasi di
pulizia con acqua calda e fredda a volontà, camere spaziose e cena e colazione come le intendiamo noi. Basti dire
che, prima di cena, l’accoglienza ai nuovi arrivati prevede l’aperitivo, servito nella bella veranda coloniale che dà
su un minigiardinetto verde, dove poltrone, divani, libri e riviste sulla geografia dell’Etiopia, sui suoi abitanti, e
perfino una rivista italiana d’epoca che stronca il discorso contro l’Italia tenuto da Hailé Selassie alla Società delle
Nazioni, invitano al relax sulle note pettinate di “Portrait in Jazz” del Bill Evans Trio e del jazz forbito di
Thelonious Monk. Solo ad Addis Abeba avremmo trovato una sistemazione pari, dopo due ore di vane ricerche a
causa del 14° African Union Summit che aveva intasato tutti gli alberghi raccomandati: una “suite” con due
camere da letto e un salone con 37 posti a sedere a meri 500 birr a notte…
Al ritorno, i doni dell’Etiopia passano in rassegna via via che si riprendono le vecchie, cattive abitudini.
Pantaloni che riuscivo a mala pena a infilarmi, ora, quattro chili giù – un bonus non previsto di questo viaggio –
calzano perfettamente, grazie alla mancanza di alcolici, alle colazioni molto occasionali (gli alberghi non usano
offrirla, e anche se lo facessero, chi mangerebbe ingera imbevuta, servita con ingera?), alle insalate che non
conoscono l’olio, alle faticose camminate necessarie per le visite e al non avere la sera a tiro di mano dolci e
cioccolata. Hanno anche contribuito un paio di giorni di malessere grazie ad un’insalata del Cottage Restaurant,
“uno dei più vecchi e dei migliori” di Addis – stando alla Bradt Guide, la vera bibbia del viaggiatore in Etiopia – e
del suo cibo svizzero e continentale, mentre tutto era filato liscio durante le tre settimane di cibo locale. Si torna a
casa, e l’acqua corrente è magicamente disponibile a qualunque ora (spesso, anche negli alberghi di categoria
media, è disponibile solo dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 22) e, incredibile dictu, a volontà sia la fredda che la calda!
Ora che la cura del corpo è di nuovo possibile, ora che non siamo più un drappello alla conquista di inesplorati
territori armati di una punta-e-clicca, riscopriamo dimensioni di noi che avevamo dimenticato e che, forse, in un
paese del terzo mondo non esistono o che comunque raramente abbiamo trovato in Etiopia: il diritto alla privacy,
al rispetto e quella pienezza dell’essere nei diversi ruoli che svolgiamo al lavoro, in famiglia, col partner.
L’educazione, che ci riscatta da una vita simile a quella degli animali, deve ancora diventare una priorità per le
famiglie che mandano i ragazzi a pascolare pecore e mucche. Che dico! Una priorità? Più esatto dire una
“possibilità”. Quanto distante sarà la scuola più vicina? Quanto può incidere sul bilancio familiare il peso di uno
studente? Per questo un esperimento sociale come quello di Awramba, trovato tra Bahar Dar e Gondar, fa ben
sperare. Attraverso i tempi e i continenti, a volte emergono questi esempi di comunità ideale, i membri delle quali
hanno rinunciato alla proprietà privata lavorando insieme e insieme guadagnando, attuando una eguaglianza di
ruoli tra i sessi e una condivisione delle risorse umane e territoriali alla quale Marx avrebbe trovato un solo
difetto: la libertà di credo religioso. Una ragazza dall’inglese migliore del nostro ci racconta le peripezie di questo
speranzoso gruppo di comunardi, mostrandoci la scuola, l’ostello, lo stanzone coi telai, la biblioteca e
un’abitazione col suo ingegnoso sistema di cottura dei cibi e di riscaldamento. Veniamo alla fine presentati alla
mente del progetto: il vecchio compare, appropriatamente fuori dai canoni, con uno zucchetto di lana verde pisello
che pare una cuffia da bagno. Memori dell’esperimento di Auroville (Kerala, India) e, più vicina a noi, anche se
screditata dalla retorica risorgimentale, della colonia di San Leucio (Caserta), voluta da Ferdinando di Borbone, e
i cui benefici per gli abitanti perdurano a tutt’oggi, auguriamo al progetto i consensi che la popolazione limitrofa
finora non gli ha concesso e che, dallo stato, ottenga l’appoggio che necessita. Abbiamo anche visitato una
cooperativa d’un gruppo di donne madri che producono oggetti di terracotta: un’iniziativa comunitaria più
commerciale ma altrettanto valida. Gli etiopi devono mettere il cervello in moto e smettere di pensare di potersi
guadagnare da vivere – per poco che possa essere necessario in quel paese – facendo i lustrascarpe: con la polvere
che c’è, una più completa assurdità è difficile da immaginare. Se gli Stati Uniti sono l’incubo dei dietologi,
l’Etiopia è l’incubo degli idraulici: nessun rubinetto funziona, e gli scaldabagni solo occasionalmente. Se il paese
vuole puntare sul turismo, meglio pavimentare le strade, preservare il patrimonio culturale e formare personale
competenti per alberghi, ristoranti e agenzie turistiche. Per ora, è solo ad Addis Abeba che le pecore per strada
sembrano fuori luogo: in ogni altra parte, sono le strade ad essere le intruse nel paesaggio, e giustamente vengono
ignorate dalle greggi e dalle mandrie, e usate come canali preferenziali dagli asinelli stracarichi di legna da ardere,
di sacchi di granaglie e di farina e d’ogni altra merce, oltre che dai muli vaganti. La strada è un fiume di animali e
di gente. Sono tanti gli etiopi, più di settanta milioni. Intorno ai numerosi palazzi a cui stanno lavorando, le
impalcature sono di pali di legno. Le barre di acciaio delle armature puntano speranzose in alto, aspettando un
ulteriore piano, come dappertutto in Africa. L’intero continente è in costruzione, al momento. Forse poi scoprirà
anche la manutenzione dell’esistente. Forse le ragazze al bar del supersucco stanno parlando della scuola per chef,
di una laurea in letteratura, e la più bella, quella col corpetto pastello, della nuova versione di Windows. Sorridono
perché il lavoro certo non mancherà. C’è così tanto da fare in Etiopia: forse occorre solo dargli tempo.
Renzo Pin
18 febbraio 2010
You might also like
- Il mistero preistorico: tratto da Pilipintò. Racconti Siciliani da Bagno per Siciliani e nonFrom EverandIl mistero preistorico: tratto da Pilipintò. Racconti Siciliani da Bagno per Siciliani e nonNo ratings yet
- Per una selva oscura: una storia fatta di storie di un passato prossimo quasi presenteFrom EverandPer una selva oscura: una storia fatta di storie di un passato prossimo quasi presenteNo ratings yet
- La Croce e Il Nulla (Quinzio, Sergio) (Z-Library)Document180 pagesLa Croce e Il Nulla (Quinzio, Sergio) (Z-Library)Martin AntonyNo ratings yet
- "L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaDocument9 pages"L'Adalgisa" Una Performance IntroduttivaAntonio BaroneNo ratings yet
- Anime agitate. Violenze e vendette in un intrico di amori malatiFrom EverandAnime agitate. Violenze e vendette in un intrico di amori malatiNo ratings yet
- Il Paese Delle StregheDocument139 pagesIl Paese Delle StregheDario MontenigroNo ratings yet
- Il vaso d'oro - Il piccolo Zaccheo detto Cinabro - Singolari pene di un direttore di teatro: Ediz. integraliFrom EverandIl vaso d'oro - Il piccolo Zaccheo detto Cinabro - Singolari pene di un direttore di teatro: Ediz. integraliNo ratings yet
- Racconti - ArchintiDocument68 pagesRacconti - Archintisimonsun70No ratings yet
- 101 luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere almeno una volta nella vitaFrom Everand101 luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere almeno una volta nella vitaNo ratings yet
- 2005 Diario Cammino Di S.FrancescoDocument19 pages2005 Diario Cammino Di S.FrancescoGuido MoriNo ratings yet
- A.V. - Leggende Della Bretagna MisteriosaDocument118 pagesA.V. - Leggende Della Bretagna MisteriosadictatormaximusssNo ratings yet
- Due Viaggiatori - Sardegna 1911. Sensazioni Di ViaggioDocument6 pagesDue Viaggiatori - Sardegna 1911. Sensazioni Di ViaggioMaurizia TintiNo ratings yet